PER “MACCHINE DEL DILUVIO”.
Stefano Massari
A Stefano
di MARCO ERCOLANI per-macchine-del-diluvio
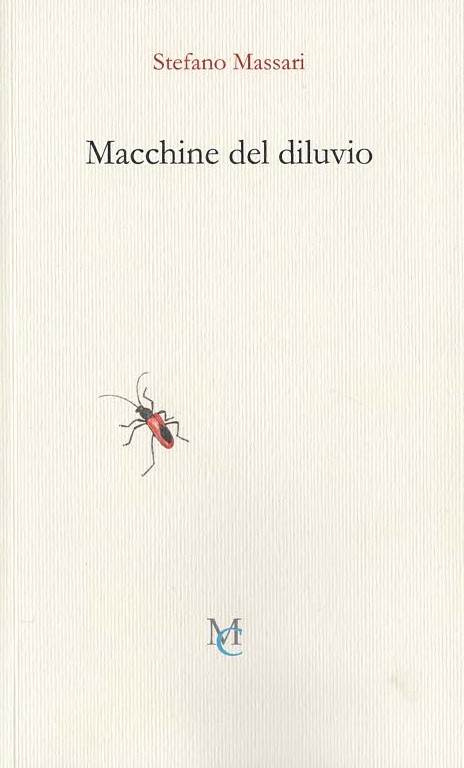
Osip Mandel’štam consigliava: «Distruggete i manoscritti, ma conservate ciò che avete tracciato a margine, per noia, per disperazione, come in sogno», Quella scrittura “tracciata a margine” e segnalata dal poeta russo, svincolata dalle convenzioni e sospesa tra estrosità del segno e imprevedibilità del senso, appartiene alle scritture non canoniche, che non vogliono essere definite come romanzi, racconti, raccolte poetiche: sono “scritture-schizzo”, dove l’artista prova i suoi sogni, abbozza le sue mappe mentali. A questo genere di scrittura sento che appartiene il tuo ultimo libro di versi, Macchine del diluvio, pubblicato nel 2022 dalla collana “Insetti” a cura di Pasquale di Palmo, alla distanza di tredici anni dal tuo Serie del ritorno. Cosa posso dirti, Stefano, al di là della prevedibile gioia di tornare a leggere i tuoi versi?
Solo questo: chi cade nella lettura del tuo libro non si trova a leggerlo parola per parola ma vaga dentro l’interminabile frammento del tuo corpo-mente che travasa linguaggi. Tu appari, con i tuoi versi, pronto a sostenere l’ennesimo combattimento contro le parole e i codici che non ti vorrebbero vivo. Chi ti legge ha subito la sensazione di trovarsi dentro un eccidio, e non sa come difendersi, dove fuggire, dove restare. Legge, ma non basta. Chi ti legge ha la sensazione di violare un segreto, di entrare da voyeur nel tuo journal intime. Il concetto stesso di “scrittura” cambia, mentre scorro i tuoi versi, e condivido il tuo “essere”: che è gesto di improvvisazione, furia vorace, pietà, riso, confidenza, fantasticheria di progetti, architettura di sogni. Penso che qualcosa di simile accadde a Nicolas de Staël quando scrisse a René Char pensando con lui un libro a quattro mani: «… non saprò mai dirti abbastanza quanto mi ha dato lavorare con te, ritrovare di colpo la passione che avevo, bambino, per i grandi cieli, le foglie d’autunno e tutta la nostalgia di un linguaggio diretto, senza precedenti, che mi trascina. Questa sera ho mille libri unici fra le mie mani per te, forse non li farò mai ma è selvaggiamente bello averli». Ma, diversamente da De Staël, non vuoi tuffarti nell’atto conclusivo e smettere la vita. Sei determinato a costruire i tuoi “libri unici”, di cui sei nomade, i tuoi personali deserti. Chi ti legge veramente ha “il buio come compagno di banco” e diventa tuo amico per sempre.
Secondo Balthus «l’artista non deve diventare narratore di storie. In pittura, l’aneddoto non dovrebbe esistere. Un quadro, un soggetto, si impongono, solo l’artista ne conosce tutte le profondità, tutte le vertigini. Non succede nulla in un quadro, esso è e basta, è per definizione o non è». Queste parole fanno riflettere alla “mancanza di storia” propria del quadro: un oggetto davanti a noi. Le parole si fanno inservibili, troppo lente e legate al senso dei discorsi, ai suoni delle diverse lingue. Il quadro si impone da sé. Quel percorso, quell’apparizione, è descritto dalle parole di Michaux: «Dipingo come scrivo, per trovarmi».
Questo ragionamento sul quadro “che si impone da sé” mi riporta a come usi tu le parole, non per narrare o inventare versi ma per imporre il tuo sigillo, tracciare il profilo di enigmi tuoi, di catastrofi personali e collettive da cui devi liberarti, non aspettando da chi ti legge altro che la “cognizione” di quello stesso dolore, la folle partecipazione a una comune speranza. Nei tuoi versi incorpori la morte e resti vivo. Chi ti legge è immerso nel silenzio fragoroso di un massacro. So che ti traversa un progetto poetico che è una proposta di “concentrazione” sull’essere vivi, di attenzione a quel “furore e mistero” (ancora Char) che è la vita. Scrive Nietzsche che l’uomo «deve nel tempo da lui scelto poter essere la volontà incarnata della non verità, la volontà dell’incertezza, la volontà del non sapere, e soprattutto la volontà della follia». Follia come scelta di un infinito vivo e pulsante contro le cose consumate e banali. «Dietro le facciate vedere quel / che mai avrei voluto sapere, dietro / ogni facciata vedere / quel che oggi non v’è» scrive Amelia Rosselli. La tua follia, il tuo ascoltare oltre di te, non ti fa mai perdere di vista quella selvaggia, carnale felicità, che il tuo corpo e i tuoi occhi contengono e svelano. Pasquale osserva, nell’introduzione al tuo libro: «La nostra epoca peraltro non ha più bisogno di parole e maestri, bensì di un silenzio che arrivi a cancellare tutto il dolore accumulato da un corpo che modula nelle sue dodici morti il capitolo di altrettante resurrezioni».
Molte le domande che vorrei farti, Stefano, perché ormai sei uscito da quel gelo che avresti voluto sopportare per sempre.
La prima viene dalla tua voce, in un nostro antico colloquio: «non abbiamo mai visto l’inizio e mai vedremo la fine . quello che facciamo sono solo ‘gesti’ appunto e astrazioni – cioè segni – di qualunque genere – che indicano il nostro passaggio . io mi divido fra queste due missioni – il segno e la custodia . cerco una totalità che può essere solo ‘momentanea’ nel punto in cui evento ed essenza delle cose ‘coincidono’ – ma non riesco ancora a spiegarmi . non ho ancora le parole – o i segni per questa visione . e anche se sono sicuro che non li avrò mai – continuo con il lavoro . molto lavoro . molto lavoro». Ancora l’invito di Baudelaire: Au travail! Come sei riuscito a varcare il silenzio? La tua risposta: restando al lavoro, attraverso il segno e la custodia, opponendoti al cancellamento della morte.
La seconda è: ma in quale luogo vivi per scrivere versi come i tuoi scorticati, ustionanti, crudeli, tenerissimi? Vivi davvero dentro di te? Ne dubito: troppo buio, troppa morte. Tu vivi come occhio aperto al mondo, nella sghemba esistenza di un poeta che non abita da buon possidente il suo cervello ma lo dilapida perché dilapidare, disperdersi, disintegrarsi, è tutto: basta che dopo si torni al lavoro e ci si sporchi le mani con le rovine. In te sento l’atroce sincerità di un Mario Benedetti, ma non la sua letale malinconia. Tu ti aggiri, affannato e furioso, nella mancanza di senso, finché non domerai almeno parzialmente le tue ombre. Come scrivo in un mio frammento: «Mettere le mani contro il muro nudo e volere, con tutta l’energia delle dita, una porta. Poi, aspettare. Occorre soltanto che la visione abbia la cura millimetrica e la forza spasmodica di inseguire quella forma necessaria, futura».
Qui di seguito trascrivo alcuni tuoi versi, che però sono e saranno appena un’eco del libro, che il lettore deve, necessariamente, leggere, come se disinnescasse un esplosivo. Se non ne ha il coraggio, si rivolga ad altri poeti che meglio di te elaborano un cammino razionale fra silenzio e parola. Il tuo, come quello dei veri visionari, ha bisogno di attraversare un deserto e di renderlo “natura disforme”, casa. Non posso, a questo punto, che attendere il tuo prossimo non-libro, dove ancora combatterai, sarai sconfitto, capirai senza capire. La materia della tua lingua sarà ancora terra e aria, come nel lungo poema che le “macchine del diluvio” formano contro la saggezza di ogni sapere e contro l’opportunismo del linguaggio lirico. Ti faccio notare che, del libro, non ho detto nulla perché devo ancora districarmi dalla tua difficile giungla di spazi e di incursioni, mentre vuoi dire il tuo “cuore di tenebra”, caro Kurtz, con fame sete risonanza desiderio destino dolore, per raggiungere le tue sparse, profetiche parole “nell’unica tua temperatura dell’alba perfetta e finale…”
(M.E.)
«cinque segni fai sul viso
il dolore serpente della fronte
nudo ciclico impaziente
il sorriso albero bambino
sulla gola del bosco che io non conosco
i capelli come un calice alzato a festa
controgola disobbediente
il labbro unito su due dita
come un nido un sigillo che non mente
lo sguardo nudo che promette e scava
come una fede divora sempre
*
parli della morte e mi guardi i polsi
e mi sorvegli la gola mentre mangio
allora con le mani giuro ti sposo
e in silenzio divido il tuo viso
dal freddo
I morti li portiamo in bocca
non sappiamo come altro fare
*
raccogliamo tre pietre sottovoce
serviranno per le teste dei padri
per raggiungere i figli
per non ferire le case
aspetta che la luce si scaldi
che inondi ogni varco
i fiori resteranno incompresi
ma saranno nostri
*
il migrato proibito negato coperto di mosche
scalciato bestemmiato con le vene del collo
disperate e sporgenti impugna i nostri bambini
sepolti urlando a noi mietitori dello sporco di dio
che mai più nessuno in questo mondo
dovrà essere padre
*
la linea di dolore dal gomito
fino alla parte interna della mano
l’ho leccata lentamente
l’ho riconosciuta
come mi impugni le tempie
mentre mangio dal tuo corpo
che vorrei diventare
ma non posso
*
come ti sfiori la gola
le dita come un flauto sul vuoto
la spina che ti piega nel grembo
lo stelo del dubbio la lingua
che leghi ai miei denti
impareremo questo coraggio
di obbedirci di curarci
di non dividerci mai più

Commenti